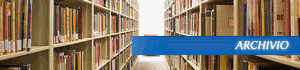La paura prevale sulla ragione, ma l’integrazione dei migranti è vitale per l’Europa
 Europa miope di fronte alle sfide dell’immigrazione
Europa miope di fronte alle sfide dell’immigrazione
Intervista di Giorgio Paolucci a Romano Prodi su Atlantide del 23 agosto 2016
La lunga esperienza maturata alla guida dell’Unione Europea e dell’Italia, e il ruolo di commissario Onu per l’Africa, fanno di Romano Prodi un interlocutore autorevole per capire come affrontare le sfide connesse ai flussi migratori che interessano il Vecchio Continente e il nostro Paese. In questa intervista manifesta la sua preoccupazione per la mancanza di una visione e di un progetto organico su un fenomeno irreversibile, e suggerisce alcune strade da intraprendere per guardare all’Africa come un partner piuttosto che come una minaccia.
Qual è il suo giudizio sul comportamento dell’Unione Europea rispetto all’emergenza immigrazione?
L’Europa sta andando in ordine sparso, mancano un progetto unitario e una strategia coordinata. Peraltro l’atteggiamento di fronte alla vicenda dei migranti è una cartina tornasole di un disorientamento generale che riguarda anche altri temi, come la politica bancaria e le politiche sociali. C’è una progressiva perdita di potere della Commissione europea e in generale delle strutture sovranazionali. Ogni Stato tende sempre di più a fare da sé. In questo modo si abdica alle idee di solidarietà, di interdipendenza e di coesione che sono alla base della stessa idea di Europa. Naturalmente quello che sta accadendo nel campo delle politiche migratorie colpisce di più, perché siamo di fronte al dramma di migliaia di vite umane, a un fenomeno “speciale” che imporrebbe risposte speciali.
È sempre più difficile distinguere nettamente le migrazioni determinate da ragioni politiche (guerre, persecuzioni, discriminazioni) da quelle di natura economica e quindi stabilire con esattezza chi ha titolo per ottenere protezione umanitaria. Facciamo i conti con strumenti normativi superati e inadeguati alle nuove situazioni, oppure si dovrebbe essere più rigorosi nella selezione degli arrivi e “rimandare a casa” chi non rientra nei criteri di protezione umanitaria?
Alcuni strumenti giuridici andrebbero riformati tenendo conto dei contesti mutati, per esempio il Regolamento di Dublino in base al quale il Paese che deve decidere sulla richiesta di asilo è il primo Paese europeo in cui si approda, mentre è noto che molti profughi hanno in mente altre destinazioni.
Chi proviene da contesti di guerra ha diritto a un’assistenza prioritaria: da questo punto di vista credo che chi arriva in questo momento dalla Siria e dalla Libia debba godere di una sorta di precedenza. Tuttavia, se non si dà vita a una forte azione diplomatica per ristabilire la pace, qualsiasi strategia di accoglienza è destinata a restare insufficiente. Rispetto alla possibilità di separare nettamente i richiedenti asilo dai cosiddetti migranti economici, non è un’operazione facile perché in molti casi le due motivazioni si intrecciano e si influenzano a vicenda.
Riflettiamo su quello che avviene nella realtà. Una famiglia fugge da un conflitto e viene ospitata in un campo profughi per un paio d’anni. Disperata, fugge in Europa. Si tratta di richiedenti d’asilo o di migranti economici? Questo vale per i siriani e per gli africani, anche se la grande sfida per l’Italia riguarda soprattutto quelli che arrivano dall’Africa. Nell’Africa subsahariana vivono oggi 962 milioni di persone, che diventeranno 1 miliardo 565 milioni nel 2035, e la popolazione in età da 20 a 39 anni salirà da 278 a 481 milioni. È verosimile che molti di loro, in mancanza di prospettive occupazionali e dovendo fare i conti in molti casi con società agitate da forti tensioni sociali e politiche, cercheranno di arrivare in Europa.
 Un’Europa che, al di là della crisi pur grave che stiamo attraversando, ha bisogno di manodopera e che è sempre più vecchia. Piaccia o non piaccia, il nostro futuro dovrà fare i conti con l’Africa. Essa è un interlocutore obbligato. E la realtà dimostra che se non c’è una visione, un progetto, se non ci occupiamo di loro, sono loro… a occuparsi di noi. In questo senso credo che la proposta del cosiddetto “Migration Compact” presentata dall’Italia all’Unione Europea colga nel segno: favorire investimenti e sviluppo è il modo migliore per frenare, nel medio e lungo periodo, i flussi migratori. Ma mi pare che per ora la proposta non abbia fatto i passi concreti che si proponeva.
Un’Europa che, al di là della crisi pur grave che stiamo attraversando, ha bisogno di manodopera e che è sempre più vecchia. Piaccia o non piaccia, il nostro futuro dovrà fare i conti con l’Africa. Essa è un interlocutore obbligato. E la realtà dimostra che se non c’è una visione, un progetto, se non ci occupiamo di loro, sono loro… a occuparsi di noi. In questo senso credo che la proposta del cosiddetto “Migration Compact” presentata dall’Italia all’Unione Europea colga nel segno: favorire investimenti e sviluppo è il modo migliore per frenare, nel medio e lungo periodo, i flussi migratori. Ma mi pare che per ora la proposta non abbia fatto i passi concreti che si proponeva.
Quanto all’idea di “rimandare a casa” chi non ha titolo per ricevere asilo politico o protezione umanitaria, osservo che certamente è necessario operare un filtro perché non possiamo accogliere tutti indiscriminatamente, ma ci sono molti modi per farlo e per associare ai rimpatri delle azioni che promuovano condizioni migliori di vita nei Paesi di origine.
Quali sono le priorità dell’Africa? E quali interventi sarebbero auspicabili da parte di un’Europa che la considerasse un partner piuttosto che un pericolo o una realtà destinata a restare marginale?
Anzitutto serve un intervento più deciso della comunità internazionale per porre fine alle guerre: l’Africa è il continente dove sono più numerose, alcune dichiarate, altre a bassa intensità. È una terra in fermento, che ha grandi potenzialità e sta crescendo, anche se a velocità ancora troppo lenta. A parte alcuni casi però – penso soprattutto alla Nigeria, all’Egitto e all’Etiopia – non ci sono mercati interni sufficientemente estesi, perciò bisogna favorire la creazione di un mercato africano, mentre gli scambi tra Paesi del continente attualmente non superano il 10 per cento del loro commercio con l’estero.
Per questo bisogna potenziare il ruolo dell’Unione Africana, che si sta (ancora faticosamente) muovendo in questa direzione. Si dovrebbe inoltre rilanciare il progetto di una Banca del Mediterraneo, e sono essenziali grandi interventi di tipo infrastrutturale: strade, ferrovie, aeroporti. Per ora l’infrastruttura che sta portando più vantaggi è il telefono cellulare, un ottimo strumento per comunicare, per unire luoghi lontani, e anche per concludere affari.
Un altro campo di intervento strategico è l’istruzione. Per arginare il fenomeno del brain drain, la fuga dei cervelli attirati (comprensibilmente) dall’Occidente, si dovrebbe incentivare la creazione di università “miste”, con una sede in Europa e l’altra in Africa. Penso ad esempio a delle business school che pongano come condizione la permanenza degli studenti nei loro Paesi al termine degli studi, e favoriscano la formazione di una classe dirigente locale capace di diventare protagonista dello sviluppo.
Come vede c’è molto da fare, ma servirebbe un’azione coordinata tra Stati africani ed Europa, invece ci si muove in ordine sparso, e gli Stati europei agiscono secondo dinamiche condizionate da vecchi rapporti coloniali che dividono il continente in aree d’influenza: inglesi, francesi, portoghesi… Si guarda indietro, prevale la rendita anziché la progettazione del futuro. L’Europa si rivela miope, e intanto altri attori sono saliti prepotentemente sulla scena accanto agli Stati Uniti, come la Cina e alcuni Paesi del Golfo.
L’insofferenza per l’immigrazione è uno dei motivi forti che hanno portato alla vittoria i sostenitori della Brexit. Prevede un effetto contagio dopo l’esito del referendum inglese e l’uscita di altri Stati dalla UE?
Non penso a un contagio anche perché per molti Stati che si lamentano, ad esempio quelli dell’Est, l’Europa è molto conveniente e l’uscita significherebbe la perdita di aiuti importanti per le loro economie. Brexit segna piuttosto un altro passaggio del progressivo sfaldamento del progetto europeo assieme all’indebolimento della Commissione e alla prevalenza di un’idea chiusa di nazione rispetto a un’idea aperta di comunità sovranazionale. È un segnale di involuzione da parte di un’Europa sempre più dimentica della sua storia e della sua vocazione, che è di ponte tra i popoli.
Sotto questo profilo è più che comprensibile e condivisibile il grido di Papa Francesco in occasione del conferimento del premio Carlo Magno il 6 maggio scorso. Ha parlato di un’Europa stanca e invecchiata, non più fertile e vitale, dove i grandi ideali che l’hanno ispirata sembrano aver perso forza attrattiva; una terra che sembra abbia perso la sua capacità generatrice e creatrice, “tentata – come ha detto testualmente – di voler assicurare e dominare spazi più che generare processi di inclusione e trasformazione; un’Europa che si va ‘trincerando’ invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società, capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori sociali nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali”.
Ed è un’Europa in cui cresce e si radica la presenza di popoli con valori e costumi talvolta in conflitto con quelli che l’hanno costituita. Ritiene che siano fondate, in questo senso, le preoccupazioni di chi guarda con timore ai migranti di cultura musulmana?
 Dal punto di vista quantitativo siamo lontani dalla cosiddetta “invasione islamica”, anche se c’è chi periodicamente ripropone questo fantasma. In Italia, ad esempio, parliamo di poco più di un milione e mezzo di persone, meno di un terzo degli immigrati che risiedono nel nostro Paese. Il problema è la presenza di correnti che non accettano i principi di una sana laicità, di una separazione tra religione e politica, che non condividono l’idea di dare a Cesare quello che è di Cesare.
Dal punto di vista quantitativo siamo lontani dalla cosiddetta “invasione islamica”, anche se c’è chi periodicamente ripropone questo fantasma. In Italia, ad esempio, parliamo di poco più di un milione e mezzo di persone, meno di un terzo degli immigrati che risiedono nel nostro Paese. Il problema è la presenza di correnti che non accettano i principi di una sana laicità, di una separazione tra religione e politica, che non condividono l’idea di dare a Cesare quello che è di Cesare.
Il che non significa, beninteso, negare o sottovalutare l’importanza della dimensione religiosa nella vita personale e la sua rilevanza sociale. Non dobbiamo chiedere ai musulmani la rinuncia alla loro fede, ma essere inflessibili nell’esigere rispetto e condivisione dei principi di cittadinanza che sono a fondamento delle nostre società. Peraltro certe pulsioni radicali presenti nel mondo islamico, spesso generate da una concezione autoreferenziale e chiusa dell’appartenenza religiosa, non possono essere denunciate come causa della debolezza della nostra identità.
Il cardinale Jean-Louis Tauran mi raccontava qualche anno fa un episodio rivelatore in questo senso: durante l’incontro con un gruppo di giovani in una scuola cattolica di Bordeaux chiese agli studenti come si potesse definire la Quaresima, e uno di loro rispose: “Una specie di Ramadan”. Una frase che la dice lunga sulla smemoratezza delle nostre radici.
Professore, in definitiva lei ha uno sguardo ottimista o pessimista davanti alle sfide che i flussi migratori portano con sé?
Sono preoccupato dalla carenza di visione, dal fatto che la paura prevale sulla ragione, dalla mancanza di una progettualità nei confronti di un fenomeno destinato a durare a lungo ma che continuiamo ad affrontare secondo una logica emergenziale.
L’Italia invecchia, le badanti straniere tengono in piedi tanti nostri anziani, le culle dei nostri ospedali si svuotano, l’Africa ribolle di giovani in cerca di futuro. Sono tutti segni che dovrebbero indurre ad affrontare i flussi migratori con politiche più forti e lungimiranti. Siamo un Paese generoso sul fronte dell’accoglienza, ma le nostre politiche di integrazione sono ancora deboli.