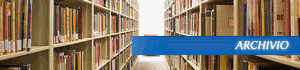La mobilità del sistema tedesco e l’incapacità italiana di prendere decisioni
L’ascensore sociale nel sistema tedesco
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 12 giugno 2011
I più recenti dati di Confindustria sull’economia italiana ci dicono che piove sul bagnato. La speranza di una ripresa dopo la crisi economica si è ancora allontanata. La produzione industriale è appena superiore a quella di un anno fa ed è abissalmente inferiore a quella prima della crisi.
Se gli Stati Uniti sono molto indietro rispetto alla Cina e se l’Europa è indietro rispetto agli Stati Uniti, l’Italia viene dopo tutti gli altri grandi paesi europei. Il problema di riacquistare efficienza e dinamismo diventa sempre più urgente.
Tra i fattori più importanti emerge la mancata crescita della produttività del lavoro. Fino a qualche anno fa la responsabilità veniva principalmente attribuita alla sua scarsa mobilità. Sono state poi introdotte norme che hanno posto rimedio a questo problema, tanto che il nostro sistema produttivo è inondato di precari e di contratti di finto apprendistato, nei quali solo la precarietà sta divenendo un punto fermo.
Una precarietà che non solo punisce nei redditi e nella prospettiva di vita un’intera generazione ma che, contro ogni previsione, non aiuta nemmeno l’efficienza del lavoro. Essa non permette infatti i percorsi professionali e i processi di apprendimento che sono necessari per fare progredire l’impresa.
Ho cercato quindi di capire quale siano le virtù della mobilità introdotta nel sistema tedesco dalle riforme messe in atto da Schroeder e confermate poi dalla Merkel. Le riforme che hanno fortemente contribuito al successo dell’industria tedesca degli ultimi anni.
Per sintetizzare quanto è avvenuto (e se qualcuno vuole averne i particolari può leggere il bell’articolo di Ciccarone e Saltari nel numero del Mulino di Gennaio) le riforme tedesche hanno puntato non sulla moltiplicazione del precariato ma sulla mobilità interna all’impresa.
Una mobilità che punta non solo sulla flessibilità dell’orario di lavoro, sul part-time e gli straordinari, ma su una mobilità attiva, attraverso la quale i lavoratori, con un ritmo costante ma soprattutto nei periodi di crisi, approfondiscono le proprie conoscenze e apprendono mansioni diverse, generalmente di livello più raffinato. Una mobilità che si esprime soprattutto in una formazione continua a tutti i livelli. La mobilità è perciò un ascensore sociale e professionale che viene soprattutto utilizzato all’interno dell’azienda e contribuisce, unitamente alle attività di Ricerca e di Sviluppo (aiutate da poderosi istituti pubblici) alla formidabile e sorprendente affermazione dell’industria tedesca nel mondo.
Questo processo è certamente più difficile in Italia, non solo per la scarsità di strutture pubbliche di appoggio, ma anche per la minore dimensione media delle nostre imprese. Tuttavia vi è un enorme spazio per lavorare in questa direzione e fare almeno in modo che il periodo di cassa integrazione venga utilizzato per apprendere e migliorare e non per dimenticare quello che si sa fare.
La vera obiezione è che la riforma di tipo tedesco esige una collaborazione attiva fra sindacati e datori di lavoro, collaborazione che raramente appartiene alla nostra cultura.
Essa richiede infatti un’attenzione prioritaria dei datori di lavoro nei confronti degli aspetti formativi (a cominciare dalle scuole tecniche di ogni livello) e una cura quotidiana del personale, anch’essa non comune nelle nostre imprese.
Simmetrica è la necessità di cambiamento da parte dei sindacati per i quali quest’attenzione quotidiana ed empirica al miglioramento della qualità del singolo lavoratore non è certo elemento prioritario.
Penso inoltre che, dal punto di vista pratico, il pluralismo sindacale (che invece di diminuire si sta sempre più accentuando) sia uno ostacolo quasi insormontabile ad un progresso condiviso sui luoghi di lavoro.
La non regolata pluralità sindacale favorisce di fatto i comportamenti competitivi e conflittuali e non i comportamenti cooperativi.
Capisco che queste elementari affermazioni confinano o addirittura superano l’utopia ma quando si tocca il fondo, come lo si sta toccando ora, anche l’utopia diventa un dovere. Ripensare radicalmente alle conseguenze sulla produttività delle attuali regole di contrattazione è perciò un dovere primario.
Naturalmente non solo le parti sociali ma anche il Governo deve credere che si possa avere un futuro migliore.
Pur nell’assoluta necessità di rispettare gli equilibri di bilancio, bisogna con forza ribadire che i cosiddetti tagli lineari (cioè tutti uguali per ogni settore) sono il segnale che nulla di nuovo si può fare e che ci si deve semplicemente limitare a stringere la cinghia aspettando che le cose migliorino da sole.
So per esperienza diretta come sia difficile stabilire priorità vincolanti quando manca la forza politica per imporre le scelte fondate non sulla forza dei ministri ma sulle necessità del Paese.
È tuttavia altrettanto chiaro che i tagli lineari sono un altro nemico del miglioramento della produttività e sono un messaggio inequivocabile che il governo ritiene di non essere in grado di prendere le decisioni necessarie per crescere.