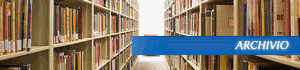Impariamo dagli antieuropeisti a essere coerentemente europei con una politica comune di rilancio dell’economia
 Unione Europea: il senso di stare insieme
Unione Europea: il senso di stare insieme
Intervista di Giacomo Costa e Paolo Foglizzo a Romano Prodi su Aggiornamenti Sociali di maggio 2014
Romano Prodi, presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004, conosce dall’interno l’Europa e le dinamiche delle sue istituzioni. I suoi contatti con la Cina e il suo impegno in Africa gli aprono lo sguardo a prospettive diverse. Che cosa vede incrociandole? Quali segnali scorge del cambiamento del posto dell’Europa nel mondo? Quali paradossi riconosce nel nostro presente e quali opportunità per il nostro futuro?
Vi è molta difficoltà a rendersi conto della specificità europea. Che cosa rende l’Europa europea?
Parto dalla mia esperienza personale: ho smesso, quando vado a parlare ai giovani, di parlare di pace, di come gli europei alla fine della seconda guerra mondiale hanno detto tutti insieme «mai più la guerra tra di noi»; i giovani lo ritengono un fatto scontato. D’altra parte, quando mio padre mi parlava della prima guerra mondiale – eravamo nel 1949-1950 – a me sembrava raccontasse fatti del Medioevo. In realtà però, con l’allargamento dell’UE verso Est abbiamo messo di colpo 80 milioni di persone in pace e su un sentiero di sviluppo, mentre appena fuori da confini dell’Unione gli scontri sono all’ordine del giorno: pensiamo alla ex Iugoslavia o adesso all’Ucraina. E che cosa motiva molti cittadini di Paesi come l’Ucraina a richiedere l’adesione all’UE? Proprio il fatto che essa è vista come fonte di sicurezza e di pace. Ciò che noi vediamo come garantito, altri Paesi lo vedono come un obiettivo a cui aspirare. La sicurezza indiscutibilmente conta: ogni volta che andavo a parlare di allargamento dell’UE, sempre mi chiedevano dalla NATO. Anzi, nei Paesi dell’ex blocco sovietico entrati nell’UE a partire dal 2004, la NATO era quasi considerata prioritaria rispetto all’Europa.
Nei nostri Paesi però, follemente, la sicurezza viene data per scontata. È giusto quindi parlare della pace, ma senza pensare che sia un tema efficace, poiché sono passati quasi settant’anni dalla fine della guerra. Il problema è piuttosto presentare un’UE positiva, non solo che ci salva dal male e non solo fondata sulla paura, ma che ci porta ad avere un ruolo nel mondo. Questo è molto più complicato, poiché la sua realizzazione esige una legislazione positiva, fantasia e una visione del futuro condivisa.
Tanti temi mostrano chiaramente come nell’UE siamo chiamati ad affrontare insieme le sfide che ci pone il mondo globalizzato: l’ecologia, l’ immigrazione, la situazione economica e finanziaria; questo però non sembra essere un dato così acquisito.
Dal punto di vista razionale è così, ma dal punto di vista istintivo lo spirito di conservazione, la nostalgia del passato, l’idea di una trascorsa grandezza e l’incertezza futura riportano alle prospettive nazionali. La questione europea viene così presentata come una grande battaglia fra istinto e razionalità, e non è detto che vinca la razionalità. Questa è la difficoltà in cui si trovano gli europeisti “razionali”, che ha condotto all’errore di affermare che l’UE è stata fatta da alcuni intellettuali. In realtà non è vero, perché De Gasperi, Adenauer, Schuman, Spaak, ecc. argomentavano anche in maniera emotiva e non esclusivamente razionale o di élite. L’UE fin dalle sue origini è un vero disegno popolare, il cui successo ne ha paradossalmente mitigato la forza: ora dobbiamo fare in modo che la razionalità ritorni e prevalga sull’istinto di conservazione.
I discorsi di personaggi quali Marine Le Pen o Beppe Grillo sono assolutamente conservatori, non offrono alcuna chiave di interpretazione del futuro. Presentano istintivamente alle persone l’idea familiare dell’Europa del passato, il ritorno agli Stati nazionali. Non hanno assunto il fatto che la globalizzazione non è una scelta, ma un cambiamento della storia. Di fronte alla “prima globalizzazione”, cioè alla scoperta dell’America alla fine del Quattrocento, gli Stati italiani sono rimasti immobili, non hanno saputo interpretarla: non hanno capito che occorrevano navi più grandi, capitali più grandi, uomini che sapessero andare oltre le frontiere, e così, da una posizione di assoluta centralità, non essendo diventati un’unica nazione, siamo stati cancellati dalla carta geografica.
Oggi la globalizzazione è totale. In fondo è questo il dramma della Germania: i tedeschi si pensano troppo grandi per l’Europa, ma in realtà sono troppo piccoli per la globalizzazione. Sono sempre al margine di una scelta storica. Qui sta il vero problema e per questo motivo insisto sul fatto che occorre un cambiamento di politica non tanto in chiave antitedesca, ma che elabori alternative di solidarietà, che per poter prevalere hanno bisogno di un’alleanza forte, seria, credibile e costruttiva proposta da Italia, Spagna, Francia insieme ad altri Paesi.
Un simile cambio di passo non lo può proporre la Francia da sola, né l’Italia, che non è sufficientemente autorevole e matura, né la Spagna, convintasi troppo rapidamente di essere “resuscitata”.
Come portare avanti questa visione ampia e di maggiore solidarietà?
In gioco qui non è l’UE, ma la democrazia: quale democrazia oggi è capace di visioni di lungo periodo? I sondaggi abbreviano troppo gli orizzonti della democrazia. Un giorno, un altissimo esponente del Partito comunista cinese mi disse: «Voi avete continuamente elezioni: comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee». Gli risposi: «Ci siamo affezionati!». Riprese: «Ci arriveremo anche noi un giorno!», ma proseguì sottolineando come, in seguito all’introduzione dei sondaggi di opinione, in realtà ogni elezione assuma un’importanza nazionale e inevitabilmente ogni politico pensi sempre all’elezione successiva e sempre prossima, piccola o grande che sia.
Un esempio: l’UE è stata rovinata dalle elezioni regionali della Renania settentrionale-Vestfalia. La crisi greca, pur gravissima dal punto di vista etico poiché in Grecia hanno imbrogliato sui conti, quando è scoppiata era del tutto trascurabile dal punto di vista quantitativo: con 30 miliardi di euro – un’inezia a livello continentale – si sarebbe messo a posto tutto. Ma la scadenza delle imminenti elezioni in Renania settentrionale-Vestfalia con i conseguenti interessi elettorali ha bloccato il processo per tre-quattro mesi e così i miliardi, gonfiati dalla speculazione, da 30 sono diventati 300. Questo vale in tutti i sistemi democratici: i nostri problemi sono sempre più di lungo periodo – che si tratti delle questioni europee, dei problemi del lavoro o di quelli previdenziali –, mentre i politici hanno un orizzonte sempre più corto. Questa è la contraddizione dell’UE, e questo favorisce coloro che dicono che le cose vanno male.
Certo vi è molto scetticismo nei confronti delle istituzioni europee, ma lo stesso vale per tutte le istituzioni nazionali: la nostra è una crisi della democrazia e istintivamente nei nostri popoli c’è la paura che altri popoli e altri sistemi politici siano più adatti a raggiungere risultati positivi.
E la crisi economica che impatto ha su queste dinamiche?
In realtà senza crisi economica avremmo molti meno antieuropei. Ma è importante chiedersi perché. La crisi economica l’hanno causata gli USA, ma, quando se ne sono accorti, in un giorno Obama ha messo sul tavolo 800 miliardi di dollari, con una semplice politica keynesiana, e tutto si è aggiustato. Avremmo dovuto fare lo stesso anche in Europa, e invece non siamo stati capaci di trovare 30 miliardi per la Grecia. Di fronte a questa differenza di reazioni politiche alla crisi, non può sembrare strano che avanzi l’antieuropeismo. Però la ragione non è che il modello europeo non ha funzionato, ma che quel modello è stato ripudiato. Istintivamente oggi si assume il vecchio modello liberista anglo-americano, che ha governato indiscusso fino allo scoppio della crisi. Solo l’inasprirsi di questa lo ha finalmente messo in discussione, ma lungo gli anni esso è penetrato così a fondo nel nostro DNA culturale che si fa fatica a pensare ad altro.
Così l’unica vera politica di difesa dell’Europa l’ha fatta la Banca centrale europea, che pure non è un organo democratico, utilizzando tutti i suoi poteri, peraltro piuttosto scarsi. Ha salvato l’euro, permettendo di conservarlo per il futuro. Questo mostra la trappola in cui siamo finiti e soprattutto è una ulteriore prova del fatto che l’Europa oggi è incapace di elaborare una visione di lungo periodo.
Ancora riguardo alla democrazia per l’Europa, un punto, importante quanto trascurato, è il bisogno di uno spazio di dibattito pubblico autentico. A livello nazionale il dibattito politico è acceso e appassionato, mentre a livello europeo tutto sembra lontano e rarefatto. Una vera democrazia ha bisogno di uno spazio di confronto non riservato ai soli tecnici ed esperti: come crearne uno a livello europeo? Ci sono segnali che si stia sviluppando?
Credo vi sia un grande ostacolo, la lingua. Parlare la stessa lingua è un fattore di amalgama, mentre le lingue ufficiali dell’UE oggi sono 24. Il problema esplose in occasione dell’allargamento del 2004, quando le lingue ufficiali passarono da 12 a 21. Fino a quel momento le traduzioni erano sempre bilaterali, ma nella nuova situazione sarebbe stato necessario un numero esponenzialmente elevato di interpreti; quindi decidemmo di adottare una lingua “pivot”, cioè una lingua ponte, che permettesse di ridurli. Se questo problema è in qualche modo risolvibile a livello dirigenziale, lo è molto più difficilmente a livello popolare. Con tutte le conseguenze, anche elettorali: se si vuole arrivare a una sfida tra due candidati a livello europeo, occorre organizzare una campagna elettorale e dei dibattiti tenendo conto del problema linguistico; perciò siamo ancora lontani da questo traguardo. Il problema del dibattito democratico a livello popolare è serio e al momento il dibattito rimane filtrato dai media che comunicano nelle diverse lingue. È comunque un dibattito politico, ma non diretto.
All’ interno di questo dibattito, quale ruolo possono avere le Chiese?
Possono aiutare a creare dei ponti al di là delle lingue?
La Chiesa cattolica ha avuto un ruolo determinante nella nascita dell’Europa. È impressionante la similitudine o identità formativa di De Gasperi, Adenauer e Schuman, tutti e tre con un livello di spiritualità molto elevato. È stato un momento molto particolare. Schuman, poi, da un punto di vista ideologico era addirittura in minoranza, visto che viveva in Francia, un Paese perlomeno areligioso.
Ho capito meglio come questo fatto non fosse scontato incontrando il presidente Chirac per parlare del preambolo della Costituzione europea, in cui era in gioco l’affermazione delle radici cristiane dell’Europa. Chirac non era antireligioso, ma mi disse: «Non è possibile. Non insistere». Capii benissimo che il passato rappresentava un ostacolo insormontabile, ma aver interpretato l’Europa come anticristiana è un errore totale. Storicamente, tuttavia, ci sono elementi che, dalla Rivoluzione francese in poi, hanno dilaniato l’Europa.
Credo che con un dialogo strutturato, ponendo correttamente i termini della questione senza impuntarsi formalmente, si sarebbe potuto superare il problema. Di fatto poi è stato inserito [nel Trattato sul funzionamento dell’UE, N.d.R.] l’articolo sul dialogo con le Chiese, che resta forte e significativo e più efficace di qualsiasi dichiarazione di principio perché guarda al futuro e non al passato.
Credo davvero che le Chiese abbiano ancora un grandissimo contributo da dare. Secondo me, poi, avere un Papa non europeo favorisce questa possibilità e aiuta le Conferenze episcopali europee a lavorare senza sentire dall’alto che c’è una nazione che pesa di più – sia essa l’Italia, la Polonia o la Germania – e senza il peso della storia passata.
Mi sono soffermato sulla Chiesa cattolica perché ha un ruolo e una dimensione particolari, ma bisogna andare oltre. La dimensione religiosa può avere un grandissimo effetto positivo, ma anche il dialogo tra diverse confessioni può aiutare il senso della fraternità, della pace. Penso al dialogo fra mondo cattolico e anglicano e, soprattutto, fra mondo cattolico e mondo ortodosso. Pensiamo al contributo che quest’ultimo potrebbe dare per risolvere alcune tensioni; non dimentichiamoci che in Europa sono molti i Paesi a predominanza ortodossa: Cipro, Grecia, Bulgaria, Romania e un giorno avremo anche la Serbia e altri Paesi balcanici. Anche il mondo anglicano ha molta importanza, pur essendo una società molto secolarizzata. Il contributo religioso è fortissimo in Europa: i concetti di pace e solidarietà, il senso di costruire barriere contro la barbarie sono profondamente cristiani. Non così il nazionalismo, la chiusura, il rifiuto della contaminazione, del contatto con l’altro.
Tornando al dibattito politico concreto, l’ impressione è che le elezioni europee continuino a restare prigioniere delle logiche politiche nazionali.
Certo, nella realtà dei fatti è così. Questa volta la campagna è un po’ più europea perché ci sono i partiti euroscettici e questo obbliga ad affrontare la questione del destino dell’Europa, ma restano ancora elezioni legate e condizionate dalla politica nazionale.
Per uscire da questa logica, un passo è il rafforzamento dei partiti a livello europeo e l’armonizzazione dei loro programmi.
Viene molto sottovalutato il fatto che sia a sinistra sia a destra nei raggruppamenti politici convivevano posizioni diametralmente opposte sull’Europa: ad esempio, parecchi socialisti francesi si erano schierati per il no al referendum sulla Costituzione europea. Ora i partiti iniziano lentamente ad avere un dibattito sui grandi temi europei a livello continentale: è un aspetto da non sottovalutare per superare il prevalere dei dibattiti politici nazionali. Ci sono ormai legami politici consolidati a livello transnazionale, sempre di più Martin Schulz viene a fare comizi in Italia, i nostri vanno in giro per l’Europa. È un embrione di intuizione politica per il futuro delle elezioni politiche europee, anche se non ancora per le prossime. È un lavoro lungo, e per certi versi un “lavoro sporco”: in una delle ultime discussioni a cui presi parte in seno alla Commissione europea, l’Europa fu attaccata per la mancanza di un demos europeo; subito dopo si bocciò l’aumento di fondi per l’Erasmus. Verrebbe da dire: «Se mi sparate a una gamba, non potete lamentarvi se non corro».
E dopo le elezioni?
Dopo queste elezioni andremo verso una grande coalizione tra partito popolare europeo e i socialisti-democratici, che può anche far fare passi in avanti all’istituzione europea, se non altro per non soccombere. Il pericolo di oggi è che si generi una frattura sistemica tra Nord e Sud, rispetto alla quale si vende l’idea che alla base ci sia una differenza etica. Il senso di sottintesa superiorità di molti politici tedeschi o svedesi è pericoloso, perché non può provocare che reazioni come la disperazione: nel caso greco, ad esempio, l’antieuropeismo è frutto della disperazione.
Che cosa c’ è da ascoltare nelle posizioni dei cosiddetti euroscettici o antieuropeisti?
Vi è moltissimo da imparare! Anzi, quando li si ascolta a fondo, si scopre che sarebbe coerente trarre dalle loro posizioni le conseguenze opposte: tutti i difetti che imputano all’Europa derivano dal fatto che di Europa ce n’è troppo poca, non troppa, come quando affermano che non possiamo essere ostaggi dei tedeschi, o che l’euro ha portato a tassi di interesse divergenti invece che convergenti. Finché l’Europa ha funzionato, cioè nei circa sette anni dall’introduzione dell’euro allo scoppio della crisi, i tassi di interesse sono stati convergenti.
Quando ho lasciato il Governo italiano nel 2008, lo spread era a quota 34. Questo perché funzionava un’Europa positiva. L’ampliarsi dello spread in anni più recenti è dovuto alla poca Europa.
Possiamo imparare dagli antieuropeisti a essere coerentemente europei. La forza popolare dell’antieuropeismo viene dal sottolineare le promesse non mantenute dell’europeismo tiepido: non siamo ancora arrivati là dove ci avete promesso di condurci. Su questo hanno ragione. In altri casi, ad esempio nel caso dell’Ungheria o della Francia, si tratta di nazionalismo puro, provocato dalle nuove paure: i cinesi, l’idraulico polacco, gli immigrati; di fronte alla paura si torna all’antico, che, in quanto già noto, sembra rassicurante.
Essere coerentemente europei vorrebbe dire promuovere una politica comune di rilancio dell’economia, con strumenti di riequilibrio come gli eurobond. Questi però non ci sono, e allora ci riduciamo a chiedere ai tedeschi di cambiare politica. Una politica di riequilibrio è anche interesse della Germania: è ora di smettere di rimproverare alla Cina di squilibrare il mondo con le sue esportazioni, quando lo squilibrio maggiore lo porta la Germania, che negli ultimi dodici mesi ha registrato un surplus della bilancia commerciale di 280 miliardi di euro! Questo sbilancia tutta l’Europa e va corretto: è un discorso ovvio e doveroso, per quanto scomodo per i tedeschi. Il punto non è chiedere ai tedeschi di dare soldi agli altri Paesi, ma di fare una politica keynesiana al loro interno, ad esempio con investimenti sulle infrastrutture, campo nel quale hanno un’arretratezza enorme rispetto alla Francia, anche se di questo nessuno parla.
Anche se non ci sono strumenti di riequilibrio a livello europeo, è ragionevole chiedere che i diversi Paesi sappiano gestire le loro politiche interne nell’ottica dell’interesse comune, che è principalmente anche il loro interesse, senza lasciarsi dominare dalle ossessioni del passato, come quella della Germania per l’inflazione. Gli uomini d’affari tedeschi sanno benissimo che sarebbe indispensabile una politica economica che dia più benzina al motore germanico, che un po’ di inflazione in più sarebbe utile, ma invece i politici tedeschi – in primis la Cancelliera – pensano che ogni stimolo all’economia sarebbe un cedimento ai Paesi del Sud. Non è un caso che la Germania sia l’unico Paese in Europa senza un forte partito populista antieuropeo. Ne esiste uno, ma alle elezioni ha preso meno del 4%. In realtà gli elettori tedeschi di orientamento nazionalista non hanno bisogno di un partito antieuropeo, perché l’idea di una “diversità” tedesca è ben difesa dalla cancelliera Merkel.
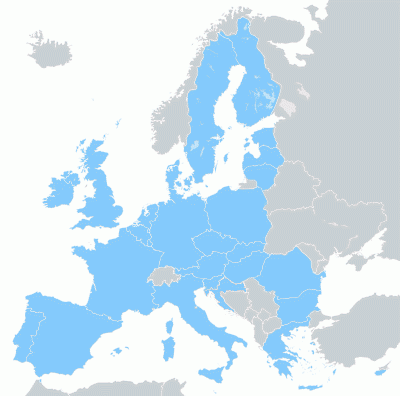 In questo quadro, secondo la sua esperienza diretta, il Presidente della Commissione quale ruolo può giocare?
In questo quadro, secondo la sua esperienza diretta, il Presidente della Commissione quale ruolo può giocare?
Un Presidente della Commissione deve esserci, ma negli ultimi anni non abbiamo mai sentito la Commissione mettersi in opposizione rispetto ai Governi. Nel 2004 lasciai la presidenza della Commissione non perché volessi tornare nella politica italiana, ma perché cambiò la maggioranza politica a livello europeo (da centrosinistra a centrodestra) e io portavo avanti una politica europea molto più all’avanguardia di quella gradita ai conservatori. Il mio grande difensore avrebbe dovuto essere Tony Blair, all’epoca l’unico leader europeo di centrosinistra, ma con Blair mi scontravo quotidianamente poiché avevamo opinioni molto diverse sull’Europa e sul mondo, a partire dall’Iraq. Quindi sono stati scelti un Presidente e una Commissione coerenti con la nuova linea “eurofredda” prevalente nei Governi europei, secondo cui la Commissione doveva avere sempre meno potere. Di fatto non l’abbiamo più sentita, mentre negli anni precedenti la Commissione si era impegnata in battaglie anche durissime nei confronti dei Governi. Perciò, per affrontare la crisi, ha fatto molto di più Mario Draghi come presidente della Banca centrale europea che il Presidente della Commissione, assumendo così un ruolo politico.
Rispetto al ruolo del Presidente della Commissione, bisogna anche tener conto dei cambiamenti istituzionali che sono avvenuti: l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio stabile e non più a rotazione [attualmente svolge questo ruolo il belga Herman Van Rompuy, N.d.R.] ha introdotto un dualismo non risolto con il Presidente della Commissione, che ne risulta indebolito. Ma questo si traduce soprattutto in una perdita di potere per l’Europa a livello internazionale: se a discutere con Obama mandiamo due persone, è chiaro fin da subito che Obama ha già vinto.
Ora la novità secondo cui nella nomina del Presidente della Commissione si deve tener conto dei risultati elettorali – per cui troveremo i nomi dei candidati sulle schede – è un fatto che ritengo interessante e che potrebbe far riguadagnare potere alla Commissione. Certo, “tener conto” non è un termine giuridicamente vincolante, per cui la nomina del nuovo Presidente potrebbe anche rovesciare l’esito delle urne, ma è un notevole progresso rispetto al passato.
Riuscirà, insieme ai più ampi poteri del Parlamento, a rimediare al deficit di democrazia spesso imputato alle istituzioni europee? Jean Monnet giustamente notava che «nulla è possibile senza gli uomini, niente è duraturo senza le istituzioni», ma d’altra parte vi è l’ idea che sono state proprio le istituzioni ad allontanare le persone.
Se ora non avessimo le istituzioni, se non avessimo l’euro, se il Parlamento non avesse ancora qualche potere, noi ora saremmo perduti, come l’Italia del Rinascimento. Le istituzioni ci consentono perlomeno di prendere tempo e di non affondare del tutto. Però le istituzioni si possono disfare: un terremoto istituzionale è sempre possibile! Anche se dal punto di vista giuridico non è previsto, quando le cose non funzionano ci sono le separazioni. E si può morire per asfissia. Non ho mai creduto all’irreversibilità delle cose, ad esempio dell’euro. Certo disfarle causerebbe danni enormi: tassi d’interesse e d’inflazione alle stelle, il caos della nostra industria, il ritorno alle svalutazioni competitive…
L’insieme delle istituzioni deve essere ridisegnato. Sarà un passaggio difficile, ma ci sono degli anticorpi nei confronti del populismo, vi è la possibilità di una reazione. Anche nell’esperienza passata l’Europa si è sempre rialzata quando era sull’orlo del burrone. Mi viene sempre in mente la sedia vuota di de Gaulle, quando la Francia aveva smesso di partecipare alla costruzione europea.
Posso solo augurarmi che riusciremo a imparare la lezione che ci viene dalla vicenda ucraina: vedere al tavolo dei negoziati sull’Ucraina gli USA e la Russia come protagonisti e nessun altro è segno delle nostre stupide divisioni. I russi giustamente ne approfittano. Al mio ultimo colloquio con Putin, quando esprimevo la tesi che l’Ucraina non possa essere né russa né europea, ma debba piuttosto essere un ponte fra Russia ed Europa, e che fino a quando la concepiamo come campo di battaglia siamo degli sciagurati, non dico che mi desse ragione, ma alla fine mi rispondeva: «Io non so con chi trattare: baltici e polacchi mi odiano, gli inglesi fanno quel che dicono gli americani e gli altri europei oscillano fra una posizione di amicizia e una di ostilità».
Potremmo aggiungere – lo aggiungo io – che nei confronti della Russia noi europei ci disponiamo con interessi del tutto divergenti: le banche inglesi custodiscono quantità enormi di denaro russo e il mercato degli immobili a Londra è dominato dagli acquisti russi. Siamo arrivati al punto di avere paura che la crisi ucraina mettesse in crisi le scuole private di élite inglesi, togliendo gli allievi russi, quelli che pagano di più. Germania e Italia dipendono dal gas russo in modo fondamentale, i Paesi baltici al 100%, pur essendo ostili alla Russia.
Non avendo una politica energetica in comune, non possiamo che essere deboli. Senza una politica economica comune, evidentemente siamo in difficoltà, ma ancora una volta perché abbiamo poca Europa, non troppa.
Gli americani ci sono e si son fatti vedere nella questione ucraina, ma considerano questi problemi sempre più lontani da loro, sono più autonomi dal punto di vista energetico; durante la sua visita in Italia, Obama non ha mancato di ricordarci che la difesa ha un costo, che l’Europa non può sempre pensare che sia gratuita.
Non possiamo chiamare la politica degli USA isolazionista, ma di fatto la loro posizione sta cambiando in modo radicale. La guerra in Iraq e in Afghanistan è stata pagata al 95% dagli USA, quella in Libia solo al 15%. In Ucraina esercitano il loro potere, ma una inchiesta ha mostrato che solo il 17% degli americani sa dove è l’Ucraina; ormai gli USA non hanno più il concetto di mondo unipolare che aveva Bush, e quindi diminuisce il loro interesse verso lo scenario ucraino. Ciononostante, Putin continua a telefonare a Obama, trattano tra loro e noi stiamo fuori. In Europa si apre la discussione solo quando arriva il segretario di Stato americano Kerry. Come dicono in Calabria: «Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia».
Poco fa ha menzionato la Cina, che lei conosce bene. Che sguardo hanno i cinesi sull’Europa?
Frequento la Cina dal 1984, quando l’IRI realizzò il primo stabilimento cinese per la produzione di tubi non saldati. Da allora non ho smesso di osservarla. In passato l’idea dell’Europa era un grande punto di riferimento per loro; adesso non lo è più. Questo è un buon esempio per comprendere bene la crisi dell’UE.
Quando nacque l’euro, i cinesi erano affascinati dall’idea di creare l’alternativa al dollaro. Mi chiedevano, un po’ increduli: «Davvero spariranno il franco e il marco? Davvero avrete una banconota uguale per tutti? Davvero la potremo mettere nelle nostre riserve?». Anche quando l’euro, nel corso dell’anno successivo alla sua introduzione, cominciò a perdere valore, continuarono a comprarlo e mi dicevano: «Nonostante tutto ci ha dato un consiglio splendido, perché l’euro tornerà a salire, ma anche e soprattutto perché se vicino al dollaro ci sarà l’euro, la Cina avrà maggior spazio nel mondo». Così hanno comprato tanti euro, che rappresentano oltre il 25% delle loro riserve. Oggi si sono fermati: da circa un anno e mezzo la loro ambizione è di mettere accanto al dollaro non più l’euro, ma il renminbi, la moneta cinese.
Quello che però mi fa più pensare è che anche il loro passaggio dall’economia degli investimenti a quella dei consumi e del welfare si basa sul modello americano. Ripeto ai cinesi che gli americani spendono in salute il 17-18% del PIL, mentre noi italiani, pur con tutte le nostre difficoltà, ne spendiamo tra il 7 e l’8% e, in media, viviamo più a lungo; e poi da noi tutti hanno la copertura sanitaria, mentre in America decine di milioni di persone ne sono prive, nonostante i tentativi di Obama. I cinesi però non sono toccati da queste osservazioni. Questo avviene perché l’UE è disunita, perché i Paesi del Nord non sono più orgogliosi della più grande conquista che hanno dato al mondo, che è il Welfare State. Non lo mettono più in vetrina. Quando si perde la coscienza della grandezza del proprio modello si finisce per avere poca influenza.
Com’ è vista invece l’UE dal lato africano, data la sua esperienza anche in quel continente?
La situazione è più complessa, anche se analoga. L’influenza della storia è molto forte: in Africa non vi è “l’Europa”, anche se l’UE è il maggior donatore; il rapporto con l’Europa passa sempre, perlomeno nell’immagine popolare, attraverso il Paese tradizionalmente partner, o, se si vuole, ex-colonizzatore. L’Africa francofona è totalmente “parigicentrica”; i Paesi anglofoni hanno ancora il loro centro di riferimento nella Gran Bretagna anche se meno di un tempo; gli USA hanno Paesi amici in Africa occidentale e sono guidati dall’amicizia politica del momento: ad esempio hanno avuto l’Egitto come partner per un lungo periodo. Ma l’unica politica per l’Africa coerente a livello continentale è quella della Cina, che pure è ancora vista come estranea.
Proprio per questo la Cina negli ultimi tempi è ossessionata dal suo soft power: non per nulla ha deciso di mandare truppe cinesi all’ONU, ha costruito lo splendido palazzo dell’Unione africana a sue spese, un palazzo più bello di quello delle Nazioni Unite, su cui ha fatto scrivere «Dono del popolo cinese al popolo africano». Se il soft power cinese è ancora estraneo al mondo africano, il loro hard power è forte, tanto che si ha la sensazione che lo sviluppo africano sia iniziato quando la Cina ha iniziato a stabilire rapporti con i Paesi africani, in modo bilaterale ma con una strategia continentale. L’impressione che la Cina abbia rimesso l’Africa al centro del mondo è forte e chiara: per quanto in maniera brutale e rozza, lo sviluppo africano si può sintetizzare in “Cina+telefonini”.
Il soft power europeo in Africa ha ancora influenza, ma l’hard power cinese sta prendendo sempre maggior rilievo. È un grande passaggio dove si vede un cambiamento del mondo. Si parla così dell’espansionismo cinese. Il punto è che la Cina ha bisogno dell’Africa più degli Stati Uniti: la Cina necessita di quantità impressionanti di cibo, materie prime ed energia e li prende dove li può trovare: inAfrica e America Latina. Gli USA invece sono quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, sono esportatori per il cibo, hanno materie prime: sono meno motivati a preoccuparsi per l’Africa.
Anche in questo caso, per quanto in modo diverso, si sta perdendo la centralità dell’Europa. Gli aiuti europei non sono molto visibili, perché ogni Paese fa da sé. Se invece fossimo un continente unito, saremmo in maniera molto più chiara i referenti principali dell’Africa, per quanto riguarda gli aiuti, gli investimenti e il commercio.
Ad altri livelli forse la stessa dinamica di divisione si ripete anche nei confronti della Turchia, con le sue ambizioni di potenza regionale.
Quella turca è una partita difficile. Io votai a favore dell’apertura dei negoziati in vista dell’ingresso della Turchia nell’UE, ma avvertendo i turchi che avrebbero potuto durare molti e molti anni, poiché la storia ha il suo peso. Non a caso, quando qualcosa la spaventava, mia nonna diceva «Mamma li turchi!». Le difficoltà si videro quando Chirac, al Consiglio europeo di Helsinki (1999), a sorpresa aprì la porta all’adesione della Turchia. Tornato in Francia capì che aveva contro tutta l’opinione pubblica. Non potendo negare quel che aveva detto, da politico astuto qual era rilanciò: sì ai negoziati, ma a condizione di tenere un referendum. Il che voleva dire che i negoziati partivano zoppi.
Secondo me, comunque, le difficoltà oggi sono da parte turca tanto quanto da parte europea, almeno da quando la Turchia ha assunto il ruolo di potenza regionale e cambia la propria politica estera a seconda del mutare dei suoi interessi in Asia centrale o in Medio Oriente: basta pensare al rapporto con Israele. Questo rende difficile gestire le relazioni, per cui ci troviamo sostanzialmente in una fase
di stallo. È bene che i negoziati procedano, ma non nascondiamoci le difficoltà. Per non parlare di quale fascino possa esercitare sulla Turchia un’Europa divisa. Vale quanto dicevo parlando della Cina.
Torniamo dunque al problema cardine: le divisioni tra europei. Riusciremo mai a superarle?
Mi viene in mente la frase attribuita, a torto o a ragione, al segretario di Stato americano Henry Kissinger: «A chi devo telefonare se voglio parlare con l’Europa?». Certo un numero di telefono unico non c’è ancora, e non c’è mai stato, ma per un certo periodo la Commissione ha rappresentato almeno un centralino, capace di smistare le chiamate. Da allora dal punto di vista operativo siamo andati indietro, mentre da quello dell’adeguamento istituzionale abbiamo le porte aperte per andare avanti.
Avremo momenti difficili, c’è la possibilità dell’errore, tuttavia le prospettive sono tutte aperte. Ma le istituzioni europee oggi sono fondamentali: impediscono gli scontri, ci proteggono, ci permettono di andare avanti.