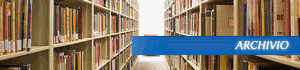Un piano industriale in tre mosse per fare ripartire l’Italia
 Piano industriale: tre mosse per il ritorno delle imprese in Italia
Piano industriale: tre mosse per il ritorno delle imprese in Italia
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 20 ottobre 2019
Per un periodo di anni, divenuto ormai così lungo da essere quasi eterno, abbiamo assistito all’esodo delle nostre imprese verso paesi con un livello salariale più basso.
Le principali destinazioni sono stati i nuovi membri dell’Unione Europea e gli altri paesi a noi vicini, dalla Polonia alla Romania, dall’Ungheria all’Albania fino a tutte le regioni dell’ex Jugoslavia. Ad essi si è aggiunto il trasferimento verso l’Asia, cominciando dalla Cina per passare dall’India, alla Thailandia e al Viet Nam.
Questo esodo ha soprattutto riguardato le aziende nelle quali il costo del lavoro era determinante e il livello tecnologico non particolarmente elevato. Era cioè una fuga dall’Italia e non un insediamento in un paese straniero per la conquista del mercato locale.
Le differenze salariali erano infatti così elevate da rendere impossibile la nostra competitività in tutti i settori nei quali non esisteva una barriera tecnologica o organizzativa.
Ricordo che quando scrissi il primo articolo di confronto dei costi industriali dopo la caduta del muro di Berlino, il titolo dell’articolo era “Uno, quattro, quaranta” perché da quaranta a uno era la differenza del salario orario fra i paesi europei più avanzati e la Cina e da quattro a uno il rapporto con i nuovi protagonisti europei.
Partendo da queste differenze le grandi imprese dell’Europa occidentale hanno trasferito verso i nuovi protagonisti europei le aziende subfornitrici o fasi particolari della produzione, in modo da aumentare la propria capacità concorrenziale. Uno dei punti di forza dell’aumento della produttività tedesca è stato quello di avere trasferito altrove, ma al proprio servizio, le produzioni più semplici.
Le cose si sono evolute nel tempo, anche se molte di queste differenze restano. I salari in Cina sono oggi tre volte inferiori ai nostri ma la produttività e l’innalzamento tecnologico dell’industria locale hanno fatto tali passi da gigante per cui il problema concorrenziale resta primario, anche se il mercato interno cinese sta diventando determinante per ogni impresa.
Più interessante è l’evoluzione della situazione europea, dove i salari dei nuovi paesi concorrenti sono continuamente aumentati e, negli ultimi mesi, hanno compiuto salti in avanti tali da cambiare i termini della concorrenza.
Spinto anche da motivi elettorali il salario minimo mensile polacco è ora nell’ordine dei 900 euro, mentre il gruppo Volkswagen ha di recente dovuto aumentare in modo massiccio le retribuzioni nelle sue filiali: è cresciuto del 12% il costo orario della Skoda nella Repubblica Ceca e del 18% il salario della fabbrica ungherese dove si produce il più elevato numero di motori per l’Audi.
Dai dati riportati dal Financial Times i costi orari sono cresciuti di oltre il 10% anche in Slovacchia, Romania e Bulgaria.
Il quadro concorrenziale sta quindi cambiando e, per le imprese italiane, si apre un nuovo orizzonte strategico.
Anche perché i salari non sono cresciuti negli ultimi dieci anni, il nostro costo orario è almeno del 30% inferiore rispetto alla Germania e agli altri paesi del nord Europa e si colloca a livelli nettamente concorrenziali rispetto alla Francia.
D’altra parte i pochi recenti casi di nuovi investimenti esteri localizzati in Italia (e messi in atto con le nostre capacità imprenditoriali e un’adeguata preparazione dei nuovi assunti) stanno dando risultati spettacolari: basta pensare al recente raddoppio della Lamborghini che produce oggi il livello di profitti più elevato nell’intero gruppo Volkswagen, che pure ha insediamenti in tutti i paesi del mondo.
È quindi ora di mettere in atto un progetto per il ritorno delle imprese in Italia e per aumentare l’arrivo di nuovi investimenti nel nostro paese: la dinamica dei cambiamenti in atto lo permette e la nostra futura sopravvivenza lo esige.
 È chiaro che la via da seguire non è certo quella di comprimere i costi del lavoro ma di aumentare la nostra stagnante produttività con un’azione congiunta fra l’operatore pubblico e gli imprenditori privati.
È chiaro che la via da seguire non è certo quella di comprimere i costi del lavoro ma di aumentare la nostra stagnante produttività con un’azione congiunta fra l’operatore pubblico e gli imprenditori privati.
Le direzioni da seguire sono chiare e provate.
In primo luogo è necessaria un’azione di emergenza verso una semplificazione della burocrazia e un comprensibile funzionamento della giustizia: quello che sta succedendo all’Ilva, un’azienda sotto la lente di tutti gli osservatori mondiali e vitale per il futuro della nostra industria, risulta del tutto incomprensibile.
In secondo luogo occorre apprestare una politica per gli investimenti pubblici e privati, attraverso lo spostamento di risorse verso le vecchie e nuove infrastrutture, dalle ferrovie fino all’intelligenza artificiale.
La terza, ma ancora più vitale direzione, è una nuova politica delle risorse umane. Non solo le scuole tecniche e le università ma un incentivo alle imprese per un elevamento del livello di tutti i partecipanti alla vita aziendale.
Capisco come l’attenzione della politica sia ora tutta concentrata sui delicati e necessari aggiustamenti del bilancio pubblico ma credo che sia ancora più importante interpretare i cambiamenti del mondo e preparare il nostro paese ad affrontarli. Non possiamo pensare che la nostra politica industriale possa limitarsi a cercare il pur necessario rimedio per le imprese che scappano.