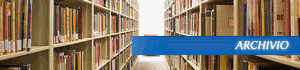Africa unita, per il futuro
Intervista di Vincenzo Giardina a Romano Prodi in copertina di Misna del 9 giugno 2011
“Bisogna coltivare l’utopia dell’integrazione interafricana” dice alla MISNA Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea, ex presidente del Consiglio italiano, ma soprattutto uomo che guarda lontano come ha confermato un suo studio per conto dell’Onu e dell’Unione africana sulle missioni di pace a sud del Sahara.
La settimana prossima a Washington la sua Fondazione per la collaborazione tra i popoli organizza una conferenza dal titolo “Africa 53 Stati – Una unione. Le nuove sfide”. È la seconda tappa di un percorso che si concluderà l’anno prossimo ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia e sede dell’Ua. Dalla guerra in Libia alla divisione del Sudan, ammette Prodi, la strada si fa più difficile…
Presidente, il 15 e 16 giugno si discuterà di integrazione africana come unica via per lo sviluppo. Ma intanto il continente si divide…
“È vero, il continente purtroppo si divide. Ma è meglio separare i problemi. L’indipendenza del Sud Sudan da Khartoum è la conclusione di un processo lunghissimo e, per questo, non stupisce. Allo stesso tempo è il segno di un continente in cui, non dico la ricerca dell’unità, ma anche solo una collaborazione più stretta tra i paesi è assolutamente difficile. Nel caso della Libia ci sono le tensioni e le proteste alimentate da un regime autoritario ma anche divisioni profonde tra Tripolitania e Cirenaica, in epoca coloniale province distinte. Un altro elemento è che nel bene e nel male Muammar Gheddafi è stato un forte contributore materiale dell’Unione africana, nonostante questo aiuto sempre rimasta povera di mezzi. Anche in futuro, dunque, l’esiguità di risorse finanziarie creerà problemi molto seri all’Ua. Debbo ammettere, d’altra parte, che non pochi Stati africani diffidano di un’Unione forte o condizionano i loro contributi alla trasparenza dei conti e alle scelte politiche. Tutti questi fattori rendono più difficile l’obiettivo di un’integrazione del continente incentrata sull’Unione africana e le sue deboli organizzazioni regionali”.
Quali sono le “nuove sfide” per il continente?
“Vediamo le difficoltà, ma non perdiamo la fede nel disegno di favorire la cooperazione tra i paesi africani. È l’unica alternativa a che il continente diventi terreno di scontro tra clan contrapposti e grandi potenze. O c’è un dialogo che coinvolga l’Europa, gli Stati Uniti, la Cina e l’Unione africana oppure la crescente influenza di Pechino si scontrerà con la resistenza della Francia nei paesi francofoni, della Gran Bretagna nei paesi anglofoni e degli Stati Uniti nei paesi amici del Golfo di Guinea. Gli africani saranno così deboli che potranno solo affidarsi a un sostegno esterno o, peggio ancora, subire una penetrazione dall’esterno. Il continente è il più grande serbatoio di energie e risorse naturali di un mondo che va verso i nove miliardi di abitanti. O obblighiamo le grandi potenze a dialogare tra loro o riprodurremo nel XXI secolo uno scenario già visto”.
A sud del Sahara esiste il rischio di un’integrazione economica che non preveda collaborazione politica?
“L’integrazione economica presuppone quella politica. Per costruire infrastrutture regionali o creare un mercato comune serve la collaborazione tra i governi. Ma Stati africani separati non sono in grado di contrapporsi all’Europa, alla Cina o all’America. Se le ex potenze coloniali adottano una politica del ‘divide et impera’ per l’Africa non c’è speranza”.
Dalla Costa d’Avorio alla Libia, l’Unione africana ha fallito nel compito di garantire la pace?
“Per forza che ha fallito! È come quando togliamo potere all’Onu e poi diciamo che non interviene. Come fa l’Unione africana a non mostrare la sua debolezza? Le mie proposte sul trasferimento di risorse per le missioni di mantenimento della pace dell’Unione africana sono state bloccate dal veto di Francia e Gran Bretagna. Non possiamo tagliare le gambe a un atleta e lamentarci che non corre. In Africa quando scoppia un conflitto si fa ricorso a truppe di vari paesi, spesso male organizzate e non coordinate tra loro; per la formazione dei contingenti di ‘peacekeeper’ mancano le strutture di finanziamento”.
Come giudica la politica italiana nella crisi libica? Dal Trattato di amicizia con Gheddafi si è passati alle promesse di “enormi somme di denaro” ai rivoltosi di Bengasi.
“Preferirei limitarmi a due osservazioni. Prima dell’inizio dell’intervento militare della Nato non sono state esperite fino in fondo le possibilità di una soluzione non conflittuale. Ogni giorno, poi, vedo continue capriole: facce feroci diventano subito indecisioni o dimostrazioni di apertura. Questi aspetti contraddittori mi rendono inquieto”.
Si è scritto di un suo ruolo come mediatore per la Libia incaricato dall’Unione europea. È una possibilità?
“Finora nessuno mi ha contattato, neanche in fase esplorativa. Poi, se nelle cancellerie si facciano di queste ipotesi…”
Mentre i caccia della Nato bombardano Tripoli, potenze emergenti come Cina, India e Brasile fanno affari.
“India e Cina si rincorrono l’un l’altra. New Delhi vorrebbe riprendere l’iniziativa anche per motivi storici, penso alla forte presenza a sud del Sahara di migranti originari dell’India. A oggi, però, la dimensione quantitativa delle attività cinesi è molto superiore. Pechino ha senz’altro contribuito allo sviluppo macroeconomico dell’Africa ma non alla ridistribuzione del reddito, cioè alla giustizia. Quanto questo sia da addebitare alla Cina o ai governi africani è un tema su cui meditare”.
E i diritti umani?
“La promozione dei diritti umani deve essere il fatto fondamentale della politica europea. Ma quando la gente muore di fame bisogna capire che ci sono necessità drammatiche alle quali si deve far fronte. Come presidente della Commissione europea mi sono trovato più volte di fronte alla scelta se cooperare con governi non democratici. Ho scelto di cooperare: boicottaggi che spesso colpiscono i tiranneggiati non sono una buona politica”.